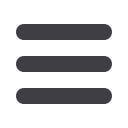

Articolo tecnico
Settembre 2012
97
www.read-eurowire.com▼
▼
Figura 3
:
Filo di 2 colori simulato nel campo di scansione. La parte superiore è
una vista in direzione longitudinale con il sensore alla sommità e la sua apertura è
indicata da un cono. La parte inferiore mostra il campo visivo della telecamera dal
punto vista dei sensori in un tempo concomitante (con valori medi dei colori sulla
destra)
▼
▼
Figura 4
:
Canali L*/ a*/ b* di un filo giallo durante 15 minuti. I piccoli grafici sono
gli istogrammi corrispondenti di ciascun canale. La FWHM degli istogrammi è L*≈2,
a*≈1,25, b*≈1,5
Prova con un colore (Giallo) 2011-04-28
a*-Canale [AU]
L*-Canale [AU]
Pertanto, è ovvio che gli errori di colore
causano considerevoli perdite di tempi di
produzione e scarti di materiale. Lo logica
conseguenza di tali considerazioni è la
necessità di un sistema di misurazione del
colore automatico in linea.
Metrica del colore
Per una migliore comprensione della
misurazione del colore, è opportuno
definire anzitutto alcuni principi di base
della percezione dei colori e della metrica
del colore. Solo per dimostrare le difficoltà
di interpretazione del “colore” per l’occhio
umano, la
Figura 1
illustra due riquadri A
e B. Chiunque classificherebbe A come
più scuro di B, ma in realtà entrambi
presentano lo stesso valore di grigio.
Questa come molte altre illusioni ottiche,
spiega perché la determinazione obiettiva
del colore per mezzo dell’occhio umano è
quasi impossibile.
Per descrivere il colore in termini fisici,
la base consiste in una parte di spettro
elettromagnetico, con lunghezze d’onda
da 350 a 800nm, che è riconosciuta
dall’occhio umano come “colore” (in ordine
ascendente viola-indaco-blu-verde-giallo-
arancio-rosso). Una migliore rappresenta-
zione fisiologica è la cosiddetta ruota
dei colori (o circolo cromatico), in cui
diversi settori circolari sono riempiti
con colori distinti. I colori che si trovano
in settori opposti sono designati come
complementari, il che rimanda al ben noto
modello RGB: con i tre colori primari, rosso
verde e blu, si possono creare tutti gli
altri colori mescolandoli adeguatamente.
Mescolando colori complementari in
proporzione 1:1 si ottiene un grigio
neutro o il bianco (mescola additiva RGB).
Questo modello si utilizza molto per le
macchine fotografiche o per i monitor,
ma si tratta di una descrizione puramente
matematica senza alcuna sensibilità per la
percezione umana del colore. Nel 1927, la
“Reich-Ausschuß für Lieferbedingungen”,
un’organizzazione tedesca per il controllo
della qualità, creò una tavola dei colori
che doveva servire come riferimento
per elementi colorati. Questa tabella è
ancor oggi molto comune nell’industria
ed è conosciuta come “RAL-Palette
classic/design/effect”
[2]
. La tabella non
include una serie ininterrotta completa
di variazioni del colore e pertanto non è
adatta per un sistema automatizzato.
Nel 1931, la “Commission Internationale
de l’Eclairage” (CIE, un’organizzazione
internazionale che si occupa di luce
e colore) propose un metodo per
l’espressione
numerica
dei
colori
includendo fattori di peso per adattare
ad una certa differenziazione visuale del
colore nella percezione umana, la stessa
distanza geometrica nello spazio di colore.
Questo tentativo fu rivisto nel 1976 ed è
noto come il modello L*a*b* (denominato
anche modello CIE-Lab)
[3]
.
Lo spazio di colore si basa su una ruota di
colori con l’asse principale Rosso-Verde
(asse a*) e Blu-Giallo (asse b*) con diverse
gradazioni. Il bordo esterno definisce il
tono, mentre la saturazione decresce verso
il grigio neutro nel centro. Perpendicolare
al centro si ha la luminosità (o luminanza)
dal nero assoluto al bianco puro (asse L*).
Si ottiene una sfera, nella quale ogni colore
visibile è rappresentato da tre coordinate
(L,a,b,
Figura 2
). (Il modello CIE-Lab è
definito esattamente solo per i colori
riflessi. Nel caso di lampade, schermi o
altre fonti luminose, esiste una descrizione
modificata conosciuta come CIE-Luv.)
Se si hanno due colori diversi nella
sfera Lab, la lunghezza geometrica dE (o
Delta-E, ΔE) del vettore fra entrambe le
Diametro
Velocità
della linea
Uno/due
colori
Obiettivo del parametro di prova
2-6mm <500m/min un colour
Deviazione del colore dE <= 3-4
2-2.5mm <500m/min due colour
Separazione del colore primario /
colore delle strisce
1.5-2mm <500m/min due colour
Cambio del colore e mancanza
di striscia
1.5-2mm <500m/min due colour
Relazione tra colore delle
strisce/colore primario
▲
▲
Tabella 2
:
Prove con tipi distinti di cavi con vari criteri di qualità

















